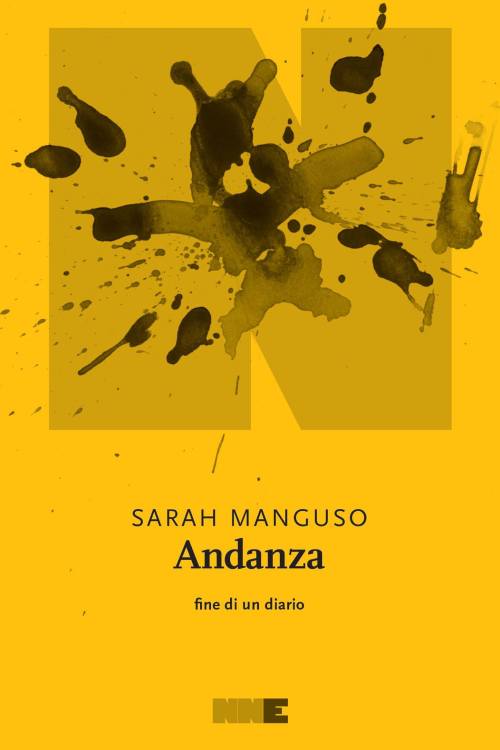
Quando ho iniziato a tradurre Andanza, mi è venuta voglia di scappare.
Non tanto per la lingua dell’autrice, a prima vista ermetica, con cui ormai ho familiarizzato. Avevo proprio paura delle riflessioni sullo scorrere del tempo, sui tentativi di fermarlo, paura di soffermarmi troppo su La vita fugge, et non s’arresta una hora. È il tema centrale del libro, un pianeta enorme intorno a cui ruotano i satelliti di scrittura, memoria, maternità, morte. Naturalmente la mia paura conteneva una buona dose di fascinazione, come per i pozzi.
Mentre Manguso ama – amava, prima di diventare madre – custodire, registrare, trattenere, io preferisco da sempre dimenticare o meglio, perché so bene che non si può sfuggire alla memoria, non avere intorno resti tangibili che possano diventare micce del ricordo. Per me è così. Infatti, senza averla mai conservata, ricordo bene una frase di Cioran:
Fin dall’infanzia percepivo lo scorrere delle ore indipendente da ogni riferimento, da ogni atto e da ogni evento, la disgiunzione del tempo da ciò che tempo non era, la sua esistenza autonoma, il suo statuto singolare, il suo imperio, la sua tirannia.
E proprio perché non ho mai trovato nessun piacere nell’archiviare e non ho mai scritto un diario, così come non salvo le foto né conservo le lettere o gli oggetti di persone care, temevo di rimanere invischiata in quelle parole così aggrappate alla memoria. Opponevo resistenza, avevo paura che la mia lingua non riuscisse a restituire quella di Sarah Manguso, che non ne fosse all’altezza, che le mie parole fossero troppo fredde o troppo calde, non so spiegarlo meglio. La lingua di Sarah Manguso è davvero così per me, una mappa di territori caldi e freddi. In pratica, non volevo farmi trascinare in quella che per me era una palude. Allora ho usato la tecnica della fuga. Traducevo un brano al giorno, la mattina presto. Lo rivedevo una prima volta la sera dopo. Poi per due, tre giorni lavoravo ad altro e ripartivo all’attacco, e ancora mi dileguavo, scappavo, e così via.
Ovviamente non era un processo conscio – l’ho capito solo durante la revisione finale – ma mi ha permesso di mettere del tempo in mezzo a parole sul tempo così dense, a pensieri così toccanti e a volte anche un po’ buffi. Forse è servito.
Mi sono resa conto solo alla fine che era un balletto, una danza con l’autrice, un’andanza.